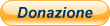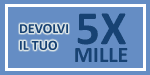| Discorso di Padre Marco Arciszewski |
 |
 |
 |
| Presentazione |
| Scritto da Padre Marco Arciszewski |
| Venerdì 08 Gennaio 2010 19:31 |
|
“PENSARE AL FUTURO CON L’ALLEGRIA DEL PASSATO” Siamo tutti cercatori di felicità, appassionati e mai sazi. Questa inquietudine ci accomuna tutti. Sembra quasi che sia la dimensione più forte e consistente dell'esistenza, il punto di incontro e di convergenza delle differenze. Non può essere che così: è la nostra vita quotidiana il luogo da cui sale la sete di felicità. Nasce con il primo anelito di vita e si spegne con l'ultimo. Nel cammino tra la nascita e la morte, siamo tutti cercatori di felicità. Tutti possiamo riconoscerci nel bisogno di felicità: ma quale felicità cerchiamo? come la cerchiamo? quali strumenti ce ne assicurano il possesso? e gli altri, in questa appassionata ricerca, che posto hanno? A quanto pare chiunque ama la vita e cerca la gioia duratura per sé e per gli altri, non riuscirà certamente ad accontentarsi di proposte che legano la felicità unicamente al possesso, alla conquista, al potere, al solo piacere, all'egoismo personale o di gruppo. E questo anche perché la nostra vita è segnata in tutte le sue fasi e le sue forme dalla fragilità: la fragilità del nascituro, del bambino, dell'anziano, del malato, del povero, dell'abbandonato, dell'emarginato, dell'immigrato, del carcerato. In tutte le età ci sono sofferenze fisiche, psichiche, sociali. Dunque come avviene per la felicità, anche l'esperienza della fragilità ci accomuna tutti. Nella vita ci sono sofferenze che arrivano contro ogni nostra aspettativa e ci sono anche sofferenze che nascono dai nostri errori e dalle nostre colpe. La fragilità quindi rimane una grande sfida: da sempre essa ha suscitato interrogativi, problemi, dubbi. Un personaggio della Bibbia è diventato una sorta di riferimento per coloro che hanno il coraggio di riflettere sul dolore. Si tratta di Giobbe: con Giobbe ci chiediamo: perché dobbiamo soffrire e morire? Perisca il giorno in cui nacqui... Perché non sono morto fin dal seno di mia madre. (Giobbe3,3.11-12;7,2-3.7) Facciamo enorme fatica ad accettare la scuola della sofferenza per scoprire che cosa sia la vita e la felicità. Nonostante tutte le nostre riflessioni e le nostre proteste, la debolezza, il dolore, la morte rimangono comunque un mistero. La morte è di casa nell'esistenza quotidiana. Bussa continuamente alla porta della vita. Dobbiamo tutti fare i conti con essa e con i suoi segni inquietanti. Oggi forse essa è presente ancora più abbondantemente di un tempo nella nostra vita, grazie alle comunicazioni e ai mezzi di informazione. Ma nello stesso tempo abbiamo esorcizzato il suo pensiero. La cultura moderna, magari, non sapendo dare una risposta a queste sfide, cerca di nasconderle con l'ebbrezza del consumismo, del piacere, del divertimento, del non pensarci. Le informazioni relative a fatti di morte vanno dosate con notizie leggere e poco impegnative. L'esperienza cristiana più autentica, invece, ci chiede di essere attenti alla morte, per essere signori della nostra vita, secondo l'orizzonte globale che la fede ci offre. L'esperienza della fragilità, del limite, della malattia e della morte può insegnarci alcune cose fondamentali. La prima è che non siamo eterni: non siamo in questo mondo per rimanere per sempre; siamo pellegrini, siamo di passaggio. La seconda è che non siamo onnipotenti: nonostante i progressi della scienza e della tecnica, la nostra vita non dipende solo da noi, la nostra fragilità è segno evidente del limite umano. Infine, l'esperienza della fragilità ci insegna che i beni più importanti sono la vita e l'amore: la malattia, ad esempio, ci costringe a mettere nel giusto ordine le cose che contano davvero. La fragilità è una grande sfida anche per la fede nel Dio di Gesù Cristo. Il Signore ci ha creati per la vita, per la felicità. Perché, allora, permette il dolore, l'invecchiamento, la morte? Quante domande di fronte a un dolore o a un lutto che fa sanguinare il cuore! Si può perfino dire che la sofferenza e la morte sono la più grossa sfida contro Dio. Le domande si moltiplicano. Ciascuno ha le proprie. A pensarci bene, cambiano le parole, ma il grido resta: abbiamo una gran voglia di vita, di felicità, e il dolore, la fragilità e la morte sembrano fatti apposta per distruggere tutto questo. Dobbiamo rassegnarci? Spegnere la voglia di vita, raffreddando i nostri slanci? Dobbiamo riconoscere che questa non è la nostra casa e rimandare tutto a un dopo, a quando saremo finalmente a casa? Ma questa casa, lontana e non sperimentabile, c'è davvero o resta un' illusione? Qualcuno va oltre, pensando: smettiamola di sognare e accontentiamoci di quello che possiamo avere tra le mani. Questa è la vita. Non è più saggio rassegnarsi? Si, la nostra esperienza quotidiana è spesso tentata di cadere nella rassegnazione, eppure si spalanca continuamente verso una forte necessità di speranza. Ma che cosa significa sperare? La speranza ha a che fare con la gioia di vivere. Suppone un futuro da attendere, da preparare, da desiderare. Sentiamo che la speranza richiede e suscita unità nel cuore: dà senso e motivazione ad ogni nostro sentimento, ogni nostra aspirazione, ogni nostro progetto. Non si può vivere senza speranza: sarebbe come vivere senza riuscire a dare una prima iniziale risposta all'interrogativo "perché sono al mondo"? Tutti abbiamo bisogno di un orizzonte di senso, per dire qualcosa di vero sul nostro futuro. Ha senso sperare che ciò che desideriamo si attui; così pure ha senso sperare di avere successo nei singoli aspetti su cui puntiamo. C'è una speranza che nasce e cresce grazie ai rapporti con le persone; anzi certi rapporti, aperti al dialogo e alla collaborazione, generano speranza, perché ci fanno sentire accolti e cercati e ci stimolano all'azione. Ma è possibile pensare e desiderare la speranza come dono che viene a noi in modo imprevedibile, come intervento non soltanto umano? Un dono che trascende le nostre possibilità, la nostra progettualità, i nostri orizzonti? Nei momenti più felici, come in quelli più profondi, anche quando sono sofferti, sogniamo una speranza che crede e che ama: la speranza di chi si sente amato, cercato, sostenuto nel quotidiano, in un crescendo di senso, di gioia, di operosità costruttiva, che va oltre la fine di tutto. È questa la speranza che viene da Dio? La speranza è la “Buona notizia” che il Vnagelo ci consegna lo ha ricordato Papa Benedetto XVI nell'Enciclica Spe salvi: "il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova" (n. 2). La prospettiva che illumina la vita, anche nel duro confronto con la morte, è appunto la speranza dischiusa dalla resurrezione di Cristo. Nell'esperienza cristiana, la speranza è una dimensione irrinunciabile, fondata nell'incontro stesso col Signore Gesù: è lui risorto da morte a illuminare il presente e ad aprire il nostro sguardo verso un futuro affidabile e bello. L'atto del morire, letto con gli occhi della speranza dell'incontro con Gesù risorto, si schiude a orizzonti che vanno oltre il limite della morte stessa. Sarà il Cristo a introdurci nella vita senza tramonto: il suo sguardo renderà la persona trasparente a se stessa, facendole assumere piena coscienza del modo in cui essa si è situata nella storia dell'amore. Siamo fatti per amare. L'amore dà la vita e vince la morte: "Se c'è in me una certezza incrollabile, essa è quella che un mondo che viene abbandonato dall'amore deve sprofondare nella morte, ma che là dove l'amore perdura, dove trionfa su tutto ciò che vorrebbe avvilire, la morte è definitivamente vinta" (Gabriel Marcel). L'amore è irradiante, contagioso, origine prima e sempre nuova della vita. Per amore siamo nati. Per amore viviamo. Essere amati è gioia. Senza amore la vita resta triste e vuota. L'amore è uscita coraggiosa da sé, per andare verso gli altri e accogliere il dono della diversità dal nostro io, superando nell’incontro l’incertezza della nostra identità e la solitudine delle nostre sicurezze. Ciascuno di noi è chiamato a esprimere nella sua storia personale e a dire a se stesso le sue buone ragioni per amare e superare le resistenze ad amare a partire dal proprio vissuto. La solidarietà che ci lega ci spinge a rompere il silenzio per farci ciascuno proposta, progetto agli altri. Sì: c'è in noi un immenso bisogno di amare e di essere amati. Davvero, "è l'amore che fa esistere" (Maurice Blondel). È l'amore che vince la morte: "Amare qualcuno significa dirgli: tu non morirai!" (Gabriel Marcel). In questo bisogno di rinascere sempre di nuovo nell’amore ci sembra riconoscibile una nostalgia: quella di un amore infinito, di un amore eterno che non avrà mai fine. Colui che ha cercato di vivere la propria vita nell'amore, partecipa dell'evento eterno dell'amore delle tre persone divine, lasciandosi amare dal Padre nell'accoglienza del Figlio, unito a lui nello Spirito Santo. Il paradiso è dunque un'immagine per dire il compimento della nostra esistenza come relazione piena con Dio e con tutte le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato. Sant' Agostino lo esprime in questo modo: "Là nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico" (Discorso 256). Davvero l'annuncio cristiano è bella notizia: ci aiuta a vivere con speranza e responsabilità la nostra vita, perché non siamo esseri viventi il cui orizzonte è la morte, ma esseri mortali il cui orizzonte è la vita. L’ultima parola non sarà della morte, ma della vita: il Dio della vita alla fine trionferà e introdurrà i redenti nello splendore della sua gloria senza fine. |